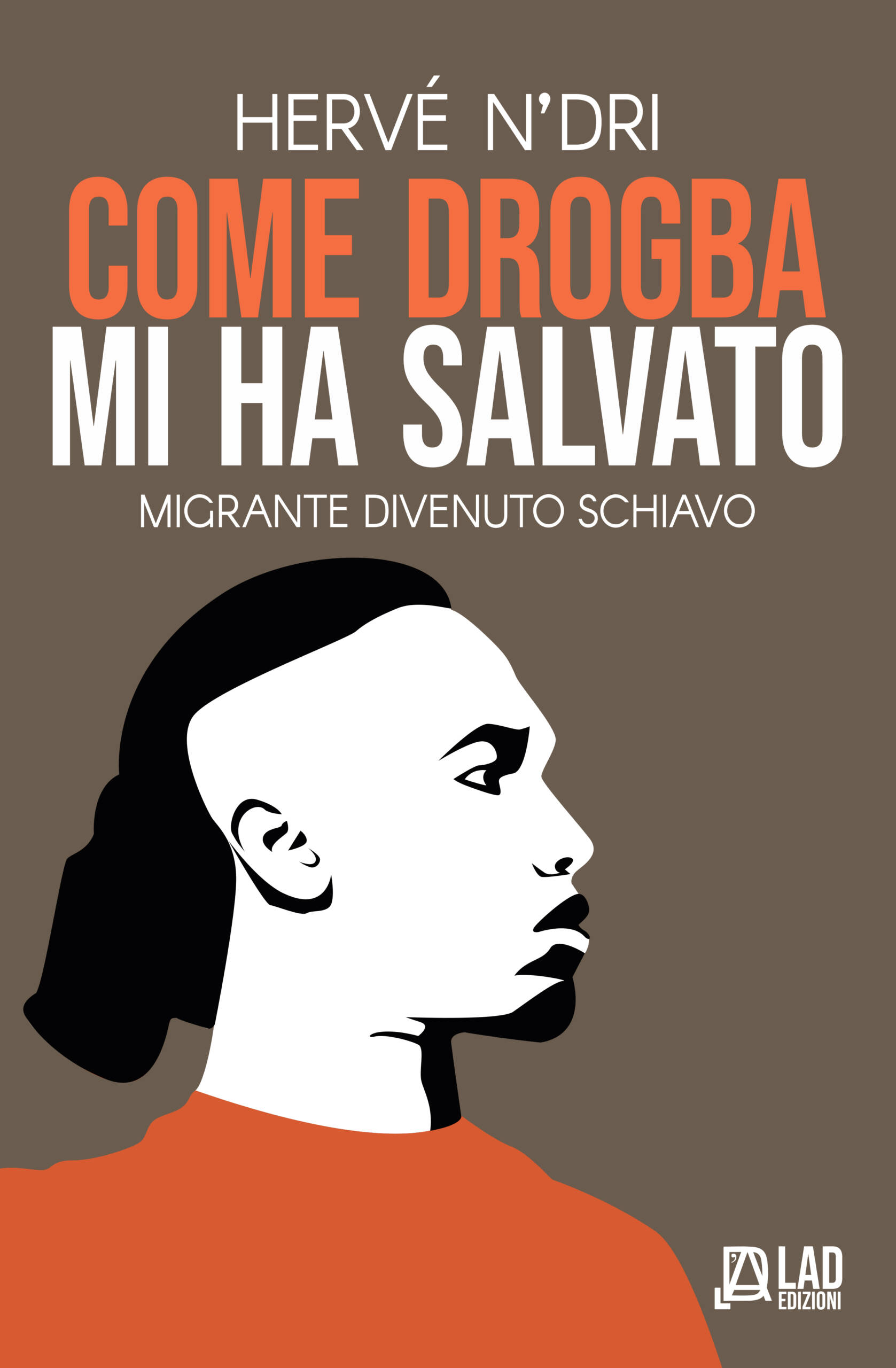Bolívar, Chávez, Maduro: una sola fiamma anticoloniale per la liberazione della Patria Grande
A 214 anni dall'Indipendenza, l'eredità di Bolívar guida la sfida per la seconda e definitiva liberazione
di Fabrizio Verde
Duecentoquattordici anni dopo il grido d’indipendenza, il riverberarsi del pensiero di Simón Bolívar, il Libertador, non solo risuona nelle piazze del Venezuela, ma ne plasma l’anima geopolitica e anticoloniale. La Rivoluzione Bolivariana, avviata da Hugo Chávez e oggi guidata da Nicolás Maduro, si presenta come l’erede consapevole e combattiva di quel progetto incompiuto: la liberazione integrale dell’America Latina e la costruzione di un ordine mondiale multipolare libero fa ogni imposizione imperialista. Un’eredità che non è mera retorica, ma una bussola morale e strategica in un contesto globale ancora segnato da asimmetrie di potere.
Simon Bolívar incarna un "esempio di volontà creatrice" la cui etica, condotta e pensiero sono indissolubili. La sua celebre affermazione – "Per la Patria bisogna essere pronti a tutti i sacrifici, non solo a quello della propria fortuna o della propria vita, ma anche a quello dell'onore e della popolarità" – trascende l’eroismo individuale per diventare un imperativo collettivo, sintetizzato poi da Martí: "La Patria è altare e non piedistallo". Per Bolívar, la Patria non era un concetto astratto o ristretto: era il popolo, era l'America intera. "Per noi la Patria viene prima", proclamava, e "Una sola deve essere la Patria di tutti gli americani", in una visione pan-americana rivoluzionaria per l’epoca. Un sentimento dinamico che, pur abbracciando il continente ("le mie braccia" dall’Orinoco al Río de la Plata), manteneva radici profonde a Caracas, "dove ricevetti la vita". Il suo patriottismo era universale: "L'uomo e la donna d'onore non hanno altra Patria che quella in cui si proteggono i diritti dei cittadini e si rispetta il carattere sacro dell'umanità". Una difesa intransigente della sovranità e della dignità umana contro ogni forma di oppressione coloniale.
Il Comandante Hugo Chávez Frías seppe tradurre questa eredità in azione geopolitica concreta nel panorama post-Guerra Fredda. Comprese che la sopravvivenza e lo sviluppo del Venezuela, e dell’America Latina tutta, passavano necessariamente per un riposizionamento strategico autonomo. La sua azione fu duplice. Da un lato, riaffermò la sovranità economica: la rinascita dell’OPEC sotto la sua guida, culminata nella storica Conferenza di Caracas del 2000, fu un atto di sfida contro l’egemonia delle multinazionali petrolifere e dei governi che ne favorivano gli interessi. Ristabilire il controllo sulla produzione e sui prezzi del petrolio significò riconquistare uno strumento fondamentale di sovranità e redistribuzione della ricchezza. Dall'altro, costruì un'integrazione anticoloniale: rifiutando l’ALCA (Area di Libero Commercio delle Americbe), progetto egemonico statunitense, Chávez lanciò un’offensiva diplomatica fondata sulla cooperazione solidale e la complementarietà economica. La nascita dell’ALBA (2004), con la sua moneta virtuale (SUCRE) e i programmi sociali transnazionali, di PETROCARIBE (2005), per l’accesso all’energia a condizioni eque, e il suo ruolo chiave in UNASUR (2008) e CELAC (2010) rappresentarono la materializzazione più avanzata del sogno bolivariano di unità continentale. Queste iniziative non erano solo economiche, ma profondamente politiche e culturali, volte a spezzare secoli di dipendenza e frammentazione imposta dall’imperialismo.
Chávez non si limitò all’emisfero occidentale. La costruzione di alleanze strategiche con Russia, Cina e Iran fu un atto di "audacia e rischio" geopolitico calcolato. Queste relazioni servirono a rompere l’isolamento e il blocco de facto imposto, soprattutto nel settore militare, consentendo il ri-equipaggiamento della FANB, un esercito moderno caratterizzato dall’aderenza ai principi dell’antimperialismo e l’anticolonialismo. Servirono anche a diversificare partnership economiche vitali per finanziare programmi di sviluppo sociale, infrastrutturale e tecnologico, come satelliti, industria e agricoltura. Contribuirono, infine, concretamente all’emergere di un mondo "pluricentrico", contrappeso all’unilateralismo. La voce di Chávez divenne centrale in sedi internazionali come l’ONU, il Movimento dei Non Allineati e il G77, denunciando le guerre imperialiste e sostenendo le lotte dei popoli per l’autodeterminazione.
La scomparsa di Chávez lasciò un vuoto immenso, ma anche un progetto chiaro e una sfida aperta. Nicolás Maduro si è trovato a guidare la Rivoluzione Bolivariana in un contesto di feroce contrapposizione internazionale. L’ex ministro degli Esteri del governo Chavez ha ribadito i principi fondamentali non negoziabili della Rivoluzione Bolivariana. In primo luogo, la difesa intransigente della sovranità: il rifiuto categorico di Maduro verso l’"aiuto umanitario" strumentalizzato, definendolo "una strategia per far credere al mondo che il Venezuela abbia bisogno di aiuto", è emblematico. È la riaffermazione del diritto all’autodeterminazione e al rifiuto di ingerenze camuffate, mentre denuncia il blocco finanziario che strangola l’economia: "Il Venezuela non andrà a mendicare nulla a nessuno nel mondo, ci bloccano miliardi di dollari nel mondo e dicono che vogliono mandare un aiuto umanitario. Il Venezuela andrà avanti con i propri mezzi", ebbe a dire quando gli imperialisti cianciavano di aiuti per il Venezuela. In secondo luogo, la diplomazia di pace e la disposizione al dialogo: nonostante l’assedio multidimensionale contro il proprio paese, Maduro ha sempre ricordato, come evidenziato anche da Abel Prieto, che "il nostro popolo ama la pace. La diplomazia bolivariana è una diplomazia di pace". La sua apertura al dialogo con l’opposizione, seppur in condizioni che rispettino la legalità costituzionale, conferma questo approccio, pur nella fermezza contro i tentativi di golpe. Infine, la continuità del progetto: l’impegno ad eseguire il Piano della Patria (Programma Socialista “Simón Bolívar”) e a garantire "la massima somma di felicità possibile" è il filo rosso che lega Bolívar, Chávez e Maduro. È la risposta concreta alla "Deuda Social" ereditata e la realizzazione della Patria come "altare" del sacrificio collettivo per il benessere comune.
A 214 anni dall’indipendenza, la Rivoluzione Bolivariana rappresenta un esperimento politico e sociale unico, profondamente radicato nel pensiero anticoloniale e unitario di Simón Bolívar e radicalizzato nell’azione globale di Hugo Chávez. È un progetto che ha osato sfidare l’ordine imperiale, promuovere un’integrazione solidale della "Nostra America" e porre al centro la sovranità popolare e la giustizia sociale. Le sfide immense che affronta – l’assedio economico, l’aggressione politica, le contraddizioni interne – sono il prezzo di questa audacia e della sua persistente attualità come "Faro Luminoso" per quanti, nel Sud del mondo, lottano per un ordine internazionale più giusto e multipolare. La difesa della sovranità venezuelana, oggi guidata da Maduro, è dunque parte integrante di questa battaglia secolare per la seconda e definitiva indipendenza dell’America Latina. Il cammino è irto di ostacoli, ma la bussola bolivariana – con il suo richiamo alla dignità, all’unità e al sacrificio per la Patria Grande – continua a indicare ben chiara la rotta da seguire.


1.gif)