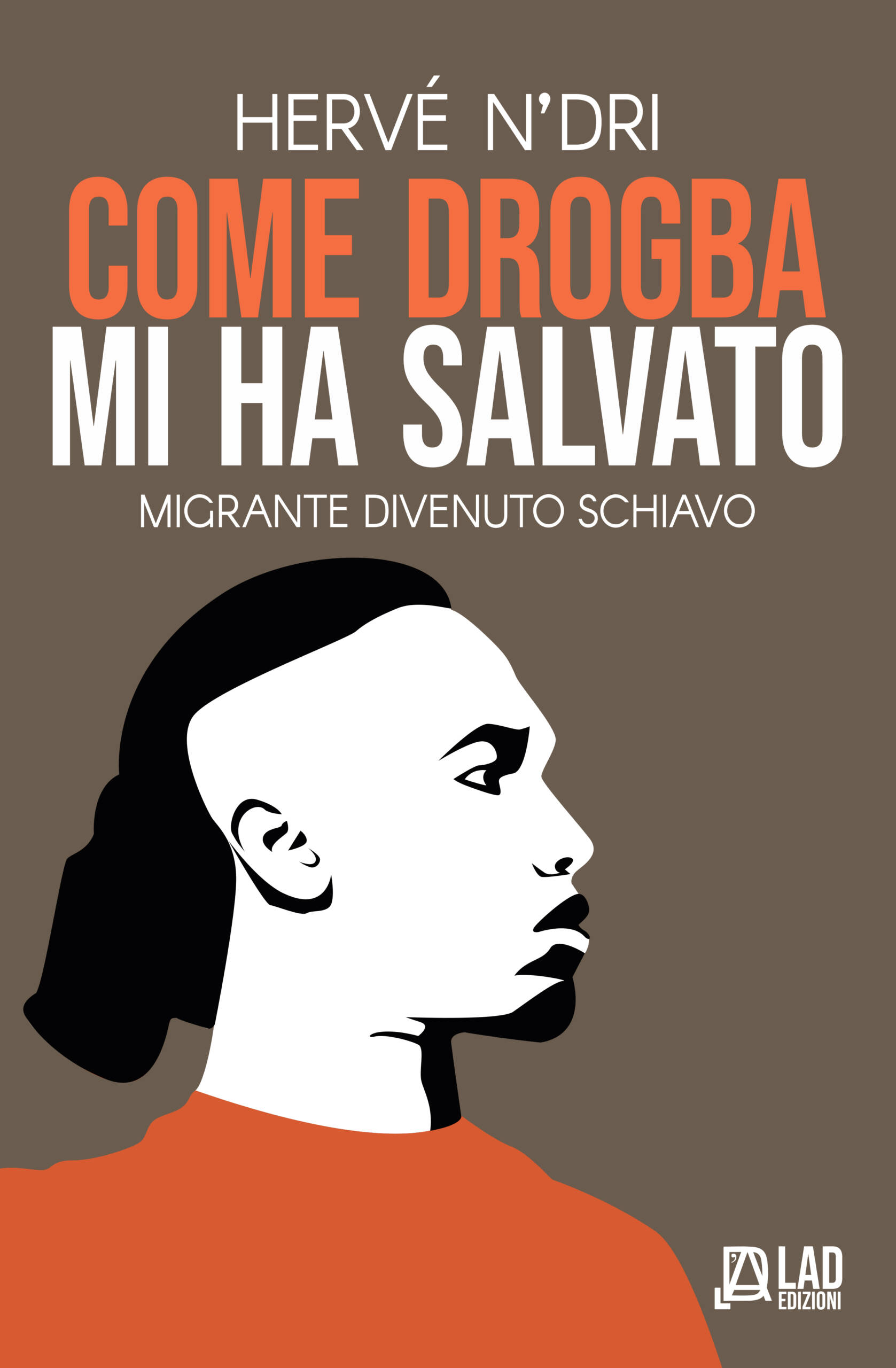L'emergenza socio-educativa e il ruolo del genitore oggi
di Angela Fais per l'AntiDiplomatico
Sempre più spesso si impongono all’ attenzione dell’opinione pubblica fatti di cronaca agghiaccianti per atrocità e cinismo e sconvolgenti per la superficialità con cui vengono commessi. Non si sbaglia nel dire che la nostra società vive ormai una emergenza socio-educativa cronica ed estremamente allarmante.
Regolarmente nei processi ai “responsabili morali” l’istituzione della famiglia è chiamata in causa. Anche nella nostra Carta Costituzionale agli artt. 29, 30, 31 si riconosce in essa un ruolo fondante, pilastro portante della società. Ma si riscontra oramai da tempo anche una sua profonda crisi, presentandosi essa come una istituzione in declino, agenzia educativa priva di qualsiasi autorevolezza. In realtà oggi raccogliamo l’esito di un complesso processo avviato molto tempo addietro.
Con la Rivoluzione industriale infatti si determina una socializzazione dei modi di produzione e della forza lavoro che pur lasciando inizialmente inalterati altri equilibri fa da preludio alla socializzazione della riproduzione, intesa quest’ultima non soltanto come prosecuzione della specie ma anche come educazione della prole e sua cura.
Le conseguenze sono di vastissima portata. Con la diffusione negli anni ‘40 di una nuova ideologia della Riforma Sociale e grazie alla forte intensificazione del welfare, dal dopo-guerra in poi si strutturano una serie di garanzie delle quali prima il cittadino non poteva godere, come ad esempio il diritto alla salute. Si garantisce a tutti la possibilità di ricevere un trattamento medico e di curarsi, correggendo così, pur se parzialmente, la disuguaglianza dei redditi.
Nel 1942 con il piano Beveridge in Gran Bretagna, e poi a seguire in tanti altri Paesi che prendono quest’ultimo come modello, lo Stato si fa carico della salute che diventa oggetto della azione statale. Accade la stessa cosa con l’istruzione che, già obbligatoria in Italia grazie alla legge Casati varata nel 1859, fu impartita nelle scuole alleggerendo la famiglia dall’incombenza di farlo entro le mura domestiche, spesso senza avere a disposizione le risorse necessarie.
Nell’arco di un tempo relativamente breve si sviluppano saperi e pratiche che di fatto ‘sottraggono’ al nucleo domestico una serie di funzioni e di processi produttivi. Educatori, assistenti sociali, riformatori del sistema penale e altri “patologi” vanno a comporre le fitte schiere di quelli che Ivan Illich, non senza scherno, chiamava “esperti” che, prendendo in consegna la famiglia, ne socializzano pressocchè tutte le funzioni parentali.
Si diffonde la convinzione che questa non sia affatto in grado di assolvere alle funzioni precedentemente espletate.
Intorno agli anni’50, e ulteriormente negli anni ’70 psicologi, sociologi e assistenti sociali, quasi tutti “gli esperti” del campo insomma, si pronunciano contro i valori della famiglia tradizionale e autoritaria a favore di “una famiglia democratica”. Secondo Bertand Russell alla famiglia si sostituisce lo Stato, alienandole una serie di funzioni: la salute nelle mani dei pediatri, l’educazione in mano ai pedagogisti, l’istruzione è compito della scuola, la professione lavorativa ora socializzata, prima svolta dal padre fuori dalle mura domestiche, non viene più tramandata di generazione in generazione.
I nuovi modi di produzione, inaugurati dalla Rivoluzione industriale e poi incrementati dallo sviluppo del neocapitalismo segnano profondamente gli equilibri della famiglia, sottoposta a una potente trasformazione che la svuota del suo compito originario. Subendo congiuntamente l’espansione della società dei consumi viene letteralmente demoralizzata.
I genitori così da educatori vengono declassati a meri distributori di attenzioni, premure, oggetti. Si crede che provvedere alla sicurezza del figlio equivalga a soddisfare ogni suo bisogno e desiderio, temendo che diversamente esso possa subire dei traumi.
Si assiste al declino della autorevolezza. Il genitore ormai molto più simile a un amichetto di mezza età, è incapace di dire di no ai propri figli persino relativamente alle azioni più semplici come fargli indossare una giacca se infreddolito, per fare un esempio banale.
Se fallisce il compito educativo diventando iperprotettivi si sospende il giudizio morale abdicando alla propria responsabilità, il genitore smette di essere il punto di riferimento. Procedendo in tal modo si impedisce quella che Heinz Kohut chiamava “delusione ottimale” o graduale, che consente al bambino di affrontare in modo sano ed equilibrato le sfide della vita, imparando gradualmente a provvedere a sé stesso. Si struttura col figlio un legame di natura narcisistica giocato in chiave seduttiva.
Dunque invasione della famiglia da parte della cultura di massa unitamente a nozioni di psicologia mal assimilate alimentano il conflitto generazionale e il crollo della autorevolezza dei genitori, sdoganando la loro impotenza rispetto al compito primario che è quello di stabilire dei punti fermi che servano al bambino come una bussola per orientarsi.
Oggi la genitorialità si rivela incapace di accedere alla responsabilità, concetto che invece riveste un ruolo cardine anche in ambito giuridico.
Nella responsabilità risuona una ingiunzione a rispondere. La ‘respons-abilità’ è proprio questa capacità a rispondere. Si risponde dei propri atti, di ciò che si dice; dobbiamo risponderne di fronte all’ Altro. Ci deve essere un soggetto che si prenda la responsabilità di dire “io”. Soltanto un io libero può rispondere alla chiamata della responsabilità che, come dice Heidegger, “ci cade addosso dal di dentro” nel senso che non è mai una scelta eteronoma la responsabilità. E’ in primo luogo autonoma. Anche in Heidegger si rintraccia questo elemento quando spiega, mettendo in risalto la singolarità insostituibile che connota la responsabilità, che nessuno può morire al posto di un altro. Non si muore per gli altri, al posto degli altri nonostante che morendo concediamo all’altro qualche attimo di vita in più. Singolarità insostituibile che esclude ogni eteronomia della responsabilità.
Eppure una aporia imprevista quanto essenziale abita il cuore stesso della responsabilità. Infatti se da una parte la condizione della responsabilità è poter prendere una decisione in “scienza e coscienza” ossia sapere ciò che si fa, perché lo si fa e in quali modalità, dall’altra coesiste anche una condizione di impossibilità, scrive J. Derrida regalandoci una profonda dissertazione sulla responsabilità. Se infatti ci si conforma a un sapere accontentandosi di seguirlo, non sarà più una decisione responsabile ma “la messa in opera tecnica di un dispositivo cognitivo”. In questo ambito giustificarsi con un: “L’ha detto l’esperto tal dei tali” non funziona perché sarebbe sempre e comunque un atto eteronomo, e in quanto tale sempre omologante e mai responsabile.
Responsabilità è indipendenza rispetto al sapere costituito, c’è in essa un elemento eretico. Airesis come scelta, scarto rispetto alla dottrina ufficiale. Secondo Derrida questa eresia è condizione essenziale della Responsabilità e la destina alla resistenza o alla dissidenza. Non si dà responsabilità senza rottura dissidente e inventiva con la tradizione, con la dottrina e con l’autorità. La responsabilità non ammette deleghe ed è paradossale ed estremamente significativo che proprio in un momento storico come quello attuale in cui la società ha dalla sua molteplici agenzie educative e altrettante figure professionali, la sofferenza e lo spaesamento giovanile e la delinquenza dilaghino senza precedenti.
Rispondere alla chiamata della responsabilità è dire "io". E' recuperare l’autorevolezza di fronte ai figli senza delegare comodamente qualcun altro a fare ciò che di fatto non potrà mai essere fatto da nessun altro al posto nostro.


1.gif)