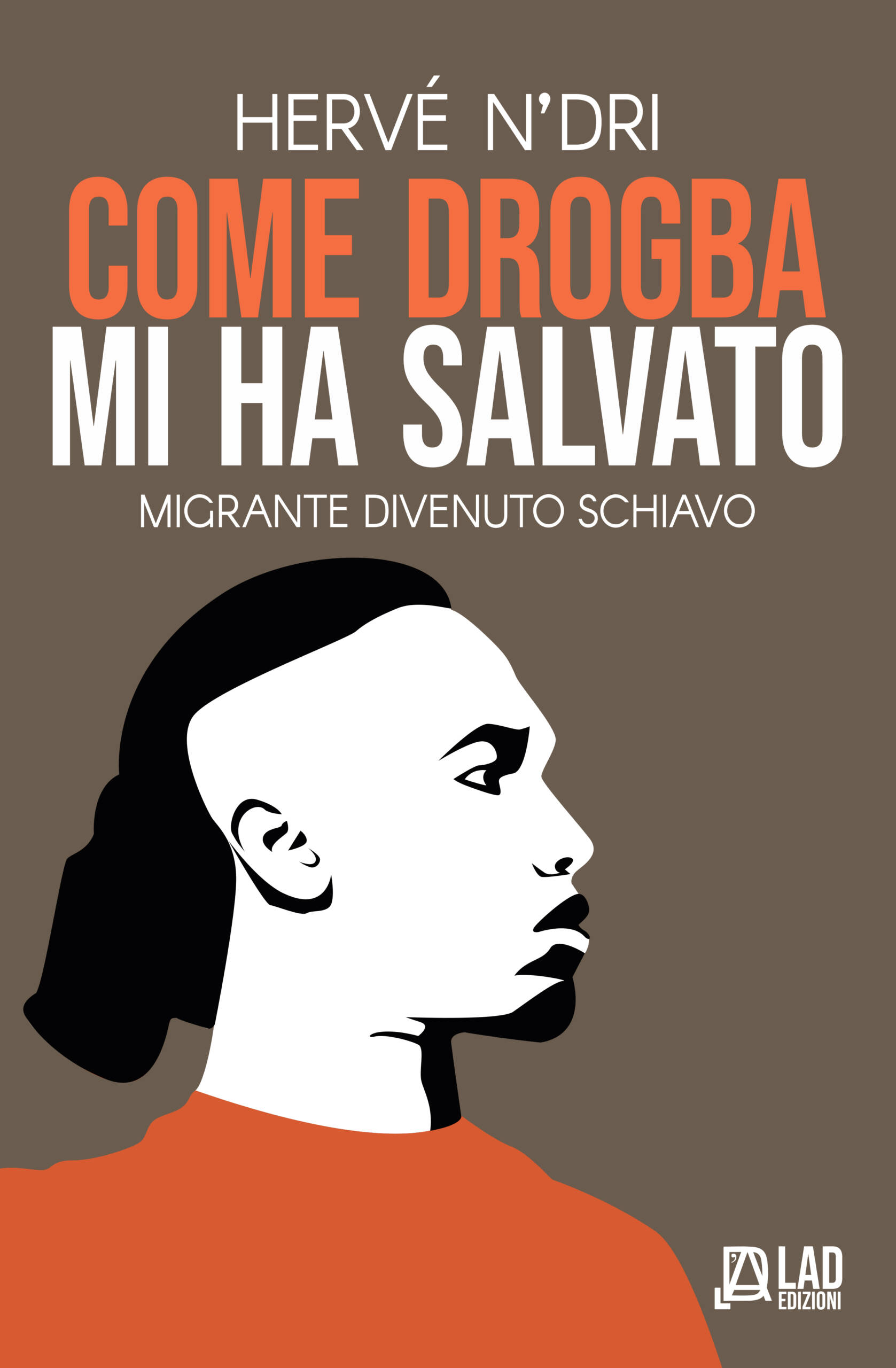I referendum del 7-8 Giugno: Un Sì speranzoso, ma poco convinto ai quesiti sul lavoro; un No deciso alla riforma della cittadinanza
di Fabio Talarico
I referendum abrogativi del 7-8 Giugno 2025 rappresentano una rara occasione di partecipazione diretta dei cittadini alla legislazione del mercato del lavoro e persino della cittadinanza. Innanzitutto, è indispensabile notare come i cinque quesiti posti di fronti a tutti gli elettori sono eterogenei. I primi quattro sono stati promossi principalmente dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), la più grande delle tre maggiori confederazioni sindacali del Belpaese. Il quinto ha tra i suoi principali promotori il partito di “centro estremo” Più Europa. Tutto sommato, il corpo elettorale ha già espresso la propria posizione in prima approssimazione: apponendo oltre 4 milioni di firme per i quesiti sul lavoro, contro le circa 637.000 di quello sulla cittadinanza.
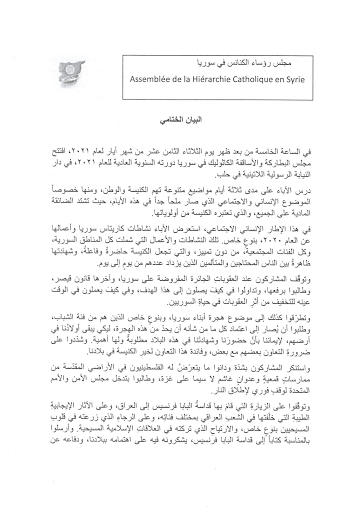
Quest’articolo esamina ciascun quesito, con particolare attenzione agli aspetti di politica economica e ai rapporti di potere sul luogo di lavoro per i primi quattro, e al potenziale svilimento del valore della cittadinanza per il quinto. In sintesi, questa analisi porta a supportare, anche se poco convintamente, il Sì ai primi quattro referenda e il No (o l’astensione) al quinto. L’argomento più convincente contro i quattro quesiti sul lavoro verte sulla sfiducia nei confronti della CGIL, loro principale promotrice (per altre critiche, meno efficaci, si veda più sotto). Infatti, tutti i sindacati confederali hanno avuto un ruolo chiave nello smantellare il sistema di protezione dei lavoratori esistito fino alla crisi finanziaria del decennio scorso. Inoltre, lo stesso partito che varò il Jobs Act ora support lo smantellamento di alcune sue parti. Il che porta, ragionevolmente, a sospettare di manovre – legislative e politiche – a venire. Tuttavia, ogni giudizi morali e d’efficacia sui sindacati e partiti italiani finirebbe inevitabilmente col condannare ogni opportunità di realizzare un cambiamento. Per quanto non possano rimediare ai danni causati dal Jobs Act e la precarizzazione del lavoro, i quattro quesiti sul lavoro danno agli elettori la possibilità di dire “Non in mio nome!”. Messi di fronte alla morte della rappresentanza e dovendo vivere con un sistema politico insensibile alle richieste che giungono attraverso gli ordinari canali elettorali, il referendum rimane l’unico strumento dalla carica democratica incontrovertibile. Al contempo, il fallimento di un referendum, sia per il mancato raggiungimento del quorum o altrimenti, segnala l’insufficiente volontà di seguire una certa linea politica. Ciò si applica in particolare al quinto quesito, il quale opera della magia referendaria per trasformare uno strumento abrogativo (che abolisce una o più norme) in un mezzo per creare nuove regole. Il fallimento del quesito sulla cittadinanza, accompagnato dal successo di almeno uno degli altri, manderebbe un messaggio chiaro alle élite partitiche e culturali italiane. Equivarrebbe alla dimostrazione matematica che i veri problemi del paese sono altri, non l’agenda “inclusiva” avanzata a piè sospinto online e sui media tradizionali.

1. Sì all’abolizione della regolamentazione dei licenziamenti illegittimi introdotta col contratto di lavoro con tutele crescenti

Il primo quesito referendario propone l’abolizione integrale di uno dei decreti emanati in attuazione del cosiddetto "Jobs Act" (Decreto Legislativo n. 23 del 2015). Questa norma ha introdotto il "contratto a tutele crescenti" per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Ciò ha comportato la sostituzione della reintegrazione in caso di licenziamento ingiusto, con la promessa di un risarcimento. In altre parole, la tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) è stata barattata per una tutela meramente compensatoria e basata sull’anzianità di servizio.
Modifiche legislative e giurisprudenziali
Alcuni critici di questo quesito hanno fatto notare che la Corte Costituzione ha più volte tacciato tale modifica di irregolarità e prodotto correttivi parziali. Tuttavia, guidati dalla CGIL, i promotori del referendum sottolineano che le tutele attuali non sono equivalenti a quelle dell’articolo 18. In particolare, il reintegro è escluso nella maggior parte dei casi di licenziamento, soprattutto per quelli motivati da ragioni economiche, salvo rare eccezioni in cui manchi del tutto una giustificazione plausibile.
Per valutare la rilevanza del referendum, è necessario esaminare le modifiche intervenute dopo il Jobs Act:
- Il Decreto Dignità del 2018: Ha aumentato le soglie dell’indennità per i licenziamenti illegittimi nel contratto a tutele crescenti, portandola da un minimo di 4 a 6 mesi di stipendio e da un massimo di 24 a 36 mesi. Tuttavia, non ha ripristinato il reintegro come misura principale, mantenendo la tutela prevalentemente economica. Il reintegro è limitato a casi specifici, come licenziamenti discriminatori o retaliatori.
- Sempre nel 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2015, nella parte non modificata dal Decreto Dignità, per il criterio di determinazione dell’indennità basato esclusivamente sull’anzianità di servizio. La Corte ha ritenuto che tale criterio violasse i “principi di eguaglianza e ragionevolezza”.
- Nel 2020, la sentenza n. 150 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2015, per la determinazione dell’indennità minima in caso di vizi formali o procedurali, sempre per violazione dei principi costituzionali.
Un confronto con l’articolo 18 dimostra che, effettivamente, queste sentenze hanno reso le indennità più proporzionate, ma non hanno reintrodotto il reintegro come misura generale. Infatti, prima del Jobs Act, l’articolo 18 prevedeva il reintegro come sanzione per i licenziamenti illegittimi, con l’obiettivo di dissuadere i datori di lavoro da comportamenti arbitrari. Con il Jobs Act, il reintegro è stato sostituito da un’indennità, e le modifiche successive non hanno ripristinato quella tutela reale, specialmente per i licenziamenti economici, dove il reintegro è possibile solo in casi eccezionali.
Impatto dell’abrogazione
L’abrogazione del Decreto Legislativo n. 23/2015 ripristinerebbe il reintegro come sanzione principale per i licenziamenti illegittimi, aumentando i costi per le aziende. Alcuni studi suggeriscono che il Jobs Act abbia paradossalmente favorito le assunzioni a tempo indeterminato. Ma quei risultati non sono riconosciuto come completi da tutti gli esperti in quanto gli autori non hanno tenuto conto del periodo generalmente favorevole in cui l’economia italiana si trovava – e che naturalmente favorisce la crescita dell’impiego, anche a tempo indeterminato. Il reintegro potrebbe portare a un mercato del lavoro più stabile e favorire la fiducia dei lavoratori. In prospettiva, si potrebbero persino notare effetti sulla produttività a lungo termine.
Inoltre, il reintegro rafforzerebbe significativamente la posizione dei lavoratori, garantendo maggiore sicurezza occupazionale e potere contrattuale. I dipendenti avrebbero più strumenti per contestare licenziamenti ingiusti, riducendo il rischio di abusi da parte dei datori di lavoro. Tuttavia, ciò potrebbe limitare la flessibilità gestionale delle imprese, riducendo la loro capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di mercato. I sindacati confederali, come la CGIL, ne uscirebbero rafforzatati, sebbene la loro coerenza e capacità nel sostenere i diritti dei lavoratori sia quantomeno dubbia.
2. Sì alla parziale abrogazione delle regole sui licenziamenti e indennità correlate nelle piccole imprese

Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, i lavoratori licenziati illegittimamente non hanno diritto al reintegro, ma ricevono un’indennità pari a 1 mese di stipendio per ogni anno di servizio, con un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità (Articolo 9, Decreto Legislativo n. 23/2015). Secondo il professor Arturo Maresca (Università La Sapienza di Roma), questa indennità è inadeguata sia come risarcimento per il danno subito dal lavoratore sia come deterrente per comportamenti arbitrari del datore di lavoro. La Corte Costituzionale ha rilevato che la differenziazione di tutele basata solo sul numero di dipendenti non riflette adeguatamente la potenzialità economica dell’azienda, suggerendo la necessità di un approccio più flessibile.
Impatto dell’abrogazione
L’abrogazione del limite massimo di sei mensilità consentirebbe ai giudici di determinare risarcimenti più equi, basati su criteri come anzianità di servizio, dimensione dell’azienda e potenzialità economica. Ciò potrebbe incentivare comportamenti più responsabili da parte dei datori di lavoro, riducendo i licenziamenti ingiustificati e promuovendo un mercato del lavoro più equo. Tuttavia, è probabile che le associazioni di settore lamenteranno della perdita di controllo del datore sulla forza lavoro.
Infatti, i lavoratori nelle piccole imprese guadagnerebbero maggiore protezione, riducendo la loro vulnerabilità rispetto ai datori di lavoro, che spesso fanno leva sulla relazione quasi personale che si sviluppa nelle piccole imprese. L’eliminazione del limite massimo di indennità darebbe ai giudici maggiore discrezionalità, potenzialmente livellando le tutele tra lavoratori di piccole e grandi imprese. Questo potrebbe migliorare le condizioni di lavoro e ridurre l’arbitrarietà nei licenziamenti senza necessariamente imporre maggiori oneri alle imprese che adottano comportamenti legali e corretti nei confronti dei dipendenti.
3. Sì all’abrogazione parziale delle norme sui contratti a tempo determinato

L’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2015 consente contratti a tempo determinato fino a 12 mesi senza causale, estendibili a 24 mesi solo per esigenze temporanee, sostituzioni o condizioni previste dai contratti collettivi. In caso di violazione, il contratto diventa a tempo indeterminato.
Impatto dell’abrogazione
L’abrogazione restringerebbe i contratti a tempo determinato a due casi: quelli previsti dai contratti collettivi o per sostituzione di altri lavoratori, con una durata massima di 24 mesi. Ciò ridurrebbe la flessibilità del mercato del lavoro, incentivando l’occupazione stabile ma limitando le opportunità temporanee in settori come il turismo o l’edilizia, con possibili effetti positivi sulla qualità dell’occupazione giovanile e la sua stabilità. Il costo di una riduzione della precarietà lavorativa sono i maggiori costi che le imprese dovranno affrontare per convertire contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Intoppo che potrebbe risolversi col supporto dell’Erario, come già accaduto in passato.
Il dover giustificare i contratti temporanei, potrebbe aumentare l’influenza dei sindacati e del sistema giudiziario nell’operazione delle imprese. In particolare, i grandi sindacati confederali vedrebbero rafforzato il loro ruolo, poiché i contratti collettivi diventerebbero centrali per permettere le assunzioni temporanee. Tuttavia, come già rilevato, i tre grandi confederali hanno da tempo dimostrato l’inabilità a difendere i diritti dei lavoratori.
4. Sì all’abolizione della norma che esclude la responsabilità solidale negli appalti
L'appalto è un contratto regolato dall’art. 1655 del Codice Civile, con cui una parte (detta appaltatore) si impegna a realizzare un’opera o un servizio per conto di un’altra parte (detta committente), in cambio di un corrispettivo in denaro. A sua volta, il subappalto è un contratto con cui l’appaltatore affida a un’altra impresa (subappaltatore) l’esecuzione di una parte dell’opera o del servizio. Si noti che il subappalto deve essere autorizzato dal committente, che quindi se ne dovrebbe assumere i rischi nel caso in cui il subappaltatore non sia un'azienda rispettabile e in regola. Tuttavia, la legge esclude la responsabilità cosiddetta “solidale” del committente e dell’appaltatore per infortuni subiti dai dipendenti di una ditta subappaltatrice.
Per esempio, se un ente pubblico affida a un’impresa la costruzione di un edificio scolastico: questo è un appalto di lavori. Mentre se l’impresa edile appaltatrice, d'accordo con l'ente pubblico, affida a una seconda ditta l’installazione degli impianti elettrici, quest’ultima è il subappaltatore. A oggi, qualora un elettricista si infortuni (s'immagini un elemento elettrico difettoso o la mancanza di dispositivi di protezione adeguati) soltanto il subappaltatore è responsabile. Mentre l’ente pubblico che ha acconsentito al subappalto ne esce indenne; a scapito dell’elettricista.
Impatto dell’abrogazione
La responsabilità solidale, specialmente nell’edilizia, darebbe ai committenti gli incentivi per richiedere standard di sicurezza più elevati dagli appaltatori e subappaltatori. Inoltre, i lavoratori nelle subappaltatrici guadagnerebbero maggiore protezione. Mentre i committenti e gli appaltatori potrebbero esercitare più pressione sui subappaltatori, alterando i rapporti contrattuali. Tutto sommato, potrebbe anche ridurre l’attrattiva del subappalto, con la possibilità di influenzare le dinamiche di mercato verso una maggiore concentrazione “verticale” delle operazioni (ad es. un’impresa edile inizierà ad assumere anche elettricisti e imbianchini).
Alcune delle critiche ricorrenti ai quattro referenda sul lavoro
Critica: “Questo referendum non abolisce il Jobs Act né de facto né de jure e i proponenti avrebbero potuto richiedere un referendum per l’eliminazione della riforma del Jobs Act.”
Il referendum del 7-8 Giugno 2025 si concentra sull’abrogazione del Decreto Legislativo n. 23/2015, una parte specifica del Jobs Act che regola il "contratto a tutele crescenti" e le tutele per i licenziamenti illegittimi. Tuttavia, il Jobs Act è un insieme complesso di testi che include misure su contratti, ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego. L’articolo 75 della Costituzione italiana limita il referendum abrogativo all’eliminazione totale o parziale di leggi o atti con valore di legge, ma non consente di abrogare pacchetti legislativi complessi né di proporre nuove norme. Di conseguenza, i proponenti non potevano richiedere un referendum per eliminare l’intera riforma del Jobs Act, ma solo per abrogare disposizioni specifiche, come fatto con il Decreto Legislativo n. 23/2015. Rispetta i vincoli costituzionali e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che richiede quesiti chiari e omogenei significa ottenere meno di quanto si vorrebbe. Ma nei limiti imposti dal sistema politico esistente difficilmente questo è probabilmente uno dei risultati migliori possibili..
Critica 2: "Il Jobs Act opera una revisione completa degli ammortizzatori sociali, per quanto riguarda il sistema delle tutele in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ma quei passaggi non sono stati toccati dai referendum."
Il Jobs Act ha riformato gli ammortizzatori sociali, come la NASpI e la Cassa Integrazione Guadagni, per migliorare le tutele in caso di perdita del lavoro. Queste misure, però, incidono direttamente sul bilancio dello Stato, poiché hanno effetto sul finanziamento del welfare state. L’articolo 75 della Costituzione esclude esplicitamente i referendum abrogativi su leggi tributarie o di bilancio. La Corte Costituzionale ha esteso tale divieto anche agli atti che, sebbene non sia di bilancio o finanziarie in nome, hanno effetti diretti sulla spesa pubblica (Sentenza n. 29 del 1987 sul referendum contro la “scala mobile”). Pertanto, i proponenti non potevano includere queste norme nel referendum, anche se parte del Jobs Act, perché fuori dai confini dell’istituto referendario.
Critica 3: "Si commenta che la possibilità di reintrodurre l’art. 18 non è stata neanche presa in considerazione."
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede il reintegro per i licenziamenti illegittimi, è stato modificato dal Decreto Legislativo n. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, sostituendolo con un’indennità economica. Abrogando questo decreto, il referendum ripristinerebbe automaticamente l’applicazione dell’articolo 18 anche ai nuovi assunti, eliminando la distinzione tra vecchi e nuovi lavoratori. Tuttavia, il referendum abrogativo in Italia, come stabilito dall’articolo 75 della Costituzione, non può proporre nuove norme, ma solo eliminare quelle esistenti. Pertanto, la reintroduzione dell’articolo 18 non è esplicitamente dichiarata, ma è una conseguenza implicita dell’abrogazione proposta (la quale inverte l’effetto dell’abrogazione implicita basata sul principio “la norma successiva vince sulla precedente”=.
5. Cittadinanza italiana: Riduzione da 10 a 5 anni di residenza legale

I cittadini di paesi non facenti parte dell’Unione Europea devono risiedere legalmente in Italia per 10 anni per richiedere la cittadinanza (Legge 91/1992). Il referendum propone di ridurre questo periodo a 5 anni, senza modificare le norme sui figli di stranieri nati in Italia. In altre parole, si tratta di un provvedimento mirato a coloro che sono giunti nel Belpaese da adulti; spesso come migranti economici.
La paradossale svalorizzazione della residenza permanente
La cittadinanza non dovrebbe essere un “premio” per il contributo economici che i migranti, arrivati in Italia da adulti, ma un riconoscimento della completa integrazione culturale. Ciò non si limata alla lingua, arrivando a includere una comprensione quantomeno intuitiva della storia politica e moral dell’Italia – per quanto complessa e contraddittoria essa sia.
Lo strumento che dovrebbe essere premiale è la residenza permanente, ottenibile dopo cinque anni di residenza legale a fronte di modesti requisiti economici e una conoscenza basilare della lingua. Anziché rendere la residenza permanente più attrattiva come base di partenza perché coloro che lo desiderano possano diventare cittadini, si cerca di aggirare il problema. Ridurre il periodo di residenza che apre la strada alla cittadinanza senza applicare criteri qualitativi che diano il giusto valore al termine “cittadino” potrebbe non favorire affatto l’integrazione.

Conclusione: Un invito al voto come atto di resistenza
Dopo aver riflettuto assieme l’articolo sui referendum del 7-8 Giugno 2025, emerge chiaramente che queste consultazioni non sono un semplice esercizio democratico, ma una chance per gli elettori di dar sentire la propria voce sulla direzione in cui sta andando il paese.
Un segnale contro la precarietà, con consapevolezza
Un “Sì” ai primi quattro quesiti rappresenta un grido contro la precarizzazione del lavoro, un fenomeno che ha eroso certezze e diritti dei giovani negli ultimi decenni. Ripristinare il reintegro per i licenziamenti illegittimi, garantire indennità più eque nelle piccole imprese, limitare i contratti a tempo determinato e introdurre la responsabilità solidale negli appalti significa puntare su un mercato del lavoro più stabile e giusto. Vero, queste misure potrebbero irrigidire alcuni aspetti del processo di assunzione, penalizzando la flessibilità delle imprese, soprattutto delle piccole e medie. Soprattutto, rafforzeranno sindacati dalla credibilità incerta. La partecipazione a questi referendum diventa allora un atto di equilibrio: un’opportunità per dire “basta” a un sistema che scarica sui lavoratori i costi della crisi, ma con la piena consapevolezza delle possibili conseguenze.
La cittadinanza come valore, non come scorciatoia
Sul quinto quesito, è più facile prendere una posizione netta: ridurre da 10 a 5 anni il requisito di residenza per la cittadinanza rischia di svilirne il significato. La cittadinanza non è un premio per la permanenza, ma il riconoscimento di un’integrazione profonda, culturale oltreché legale. Un “No” o un’astensione qui non è solo un rifiuto tecnico, ma un messaggio politico: i problemi dell’Italia non si risolvono con un’agenda inclusiva di facciata, mentre le vere urgenze – lavoro, equità, sicurezza – rimangono inascoltate. Il fallimento di questo quesito, specie se accompagnato dal successo di quelli sul lavoro, direbbe alle élite che i cittadini pretendono priorità diverse.
Il potere della partecipazione
In un sistema politico spesso sordo, il referendum è l’unica arma della democrazia diretta. Non partecipare, o farlo senza informarsi, significa lasciare ad altri il compito di disegnare il domani. I referendum del 7-8 Giugno 2025 ci chiedono di scegliere: tra precarietà e stabilità, tra flessibilità e diritti, tra un’identità nazionale svenduta e una da difendere. Ogni voto è un mattone nel futuro del Paese.


1.gif)